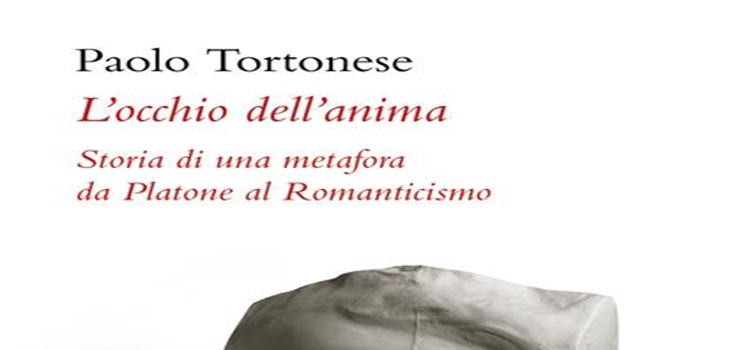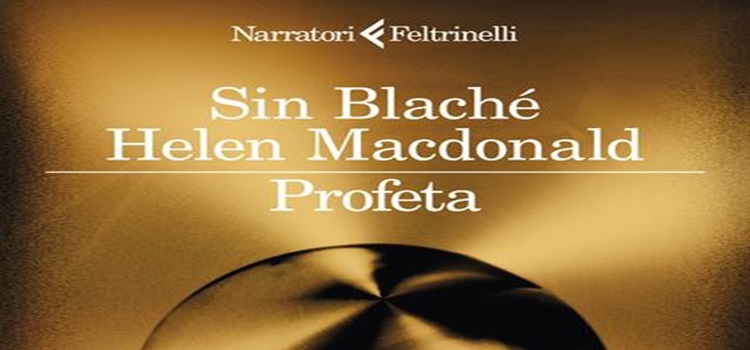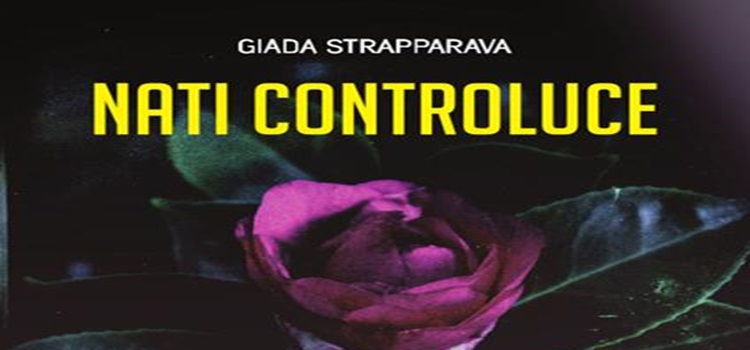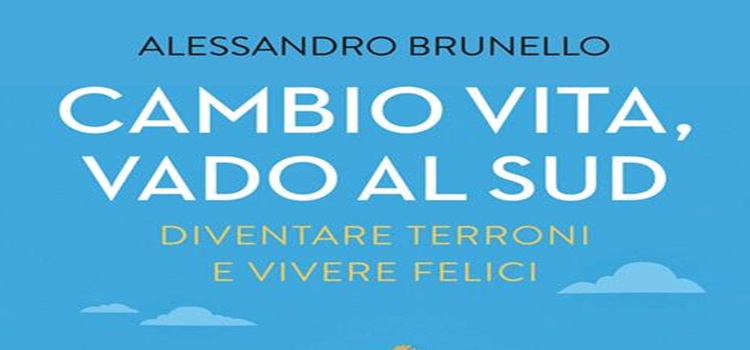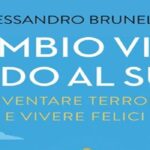Titolo: L’occhio dell’anima
Sottotitolo: Storia di una metafora da Platone al Romanticismo
Autore: Paolo Tortonese
Editore: Mauvais Livres
Collana: L’ Ornitorinco. La collana dei fuori collana
Pagine: 375
Prezzo: € 25,00
Uscita: 30 ottobre 2024
“Limpido ed erudito, questo bel libro racconta la storia dell’occhio dell’anima, metafora lanciata da Platone, ripresa nel corso dei secoli da Plotino, Sant’Agostino, Marsilio Ficino, e che permetterà più tardi ai romantici d’immaginare una psicologia moderna dell’arte.”
Thomas Pavel
Trama
Questo libro percorre la storia di una metafora, l’occhio dell’anima, attraverso la quale si concepisce un organo della conoscenza nettamente separato dalla sensazione. A partire da Platone, che l’ha inaugurata, questa metafora segna la distinzione radicale tra le facoltà intellettive e lo sguardo sensibile, ma paradossalmente riunisce in un’unica immagine le due opposte percezioni: quella dell’intelletto e quella dell’occhio.
Come se la conoscenza potesse esprimersi solo confrontandola con ciò che le si oppone. Nel corso dei secoli le metafore ottiche della conoscenza hanno conosciuto une lunga evoluzione: estetizzate da Plotino, cristianizzate da sant’Agostino o da Marsilio Ficino, sono state riprese dai romantici, filosofi, poeti, romanzieri, che le hanno nutrite di nuovi contenuti, trasformandole in problematici crocevia, dove si intersecano le vecchie esigenze del platonismo, le nuove prospettive del criticismo, i dubbi del materialismo, la concezione emergente della psiche moderna.
Nelle opere di autori diversi come Schelling, Joubert, Coleridge, Hugo o Balzac, il ritorno a Platone coincide con la rottura romantica e dà vita a immagini in cui si mescolano e confondono i destini della logica e dell’analogia.
Indice:
Orientamento dello sguardo
Tre tappe romantiche
Dalla metafisica alla psicologia
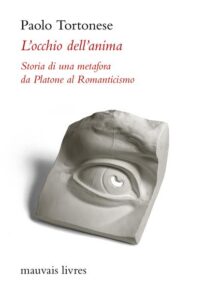
Incipit introduzione
“In Letteratura europea e Medio Evo latino, Ernst Robert Curtius ha dedicato una mezza pagina alla metafora degli «occhi dell’anima», ricordando la sua origine nell’opera di Platone e la sua presenza attraverso i secoli:
Da allora, l’immagine «occhio dell’anima» ha goduto largo favore presso gli autori, sia pagani sia ecclesiastici. Con essa, la funzione visiva dell’organo reale viene trasferita al patrimonio delle conoscenze spirituali. A sensi esterni si associano sensi interiori.
Curtius cita soltanto Cicerone, Luciano e Origene tra gli autori che hanno usato questa espressione e passa rapida- mente ad altre parti del corpo diventate oggetto di metafora: l’orecchio, il cuore, la schiena, le ginocchia, ecc. Ritorna agli occhi quando cita Dante: «occhi della ragione, dell’anima, dell’intelletto»², «agute luci de lo ‘ntelletto»³ e prosegue il suo cammino nella foresta delle metafore tradizionali…”
Incipit primo capitolo
“Nei Misteri di Parigi, Rodolphe infligge al Maître d’école una strana punizione. Avendolo fatto prigioniero, invece di consegnarlo alla giustizia, o di giustiziarlo lui stesso, lo condanna alla cecità:
Sì… per sempre isolato dal mondo esterno… sarai obbligato a guardare sempre dentro di te… e allora, spero, la tua fronte annerita dall’infamia arrossirà di vergogna…
Il castigo è messo in atto immediatamente e il Maître d’école si ritrova libero di andare a espiare nel buio i suoi orribili peccati. È una soluzione pratica per un romanziere che è solo all’inizio del suo romanzo e avrà ancora bisogno del suo criminale…”
Biografia
Formatosi in Italia, emigrato come centinaia di altri studiosi, Paolo Tortonese ha sempre insegnato in Francia. Dal 2006 è professore ordinario di letteratura francese all’università Sorbonne Nouvelle, a Parigi. Ha scritto libri e articoli sulla letteratura dell’Ottocento, in particolare sul romanzo, ma i suoi studi riguardano anche la storia delle teorie della rappresentazione, nonché i rapporti tra la letteratura, l’etica, l’estetica. Il suo libro L’uomo in azione, letteratura e mimesis da Aristotele a Zola è stato pubblicato da Carocci nel 2023.